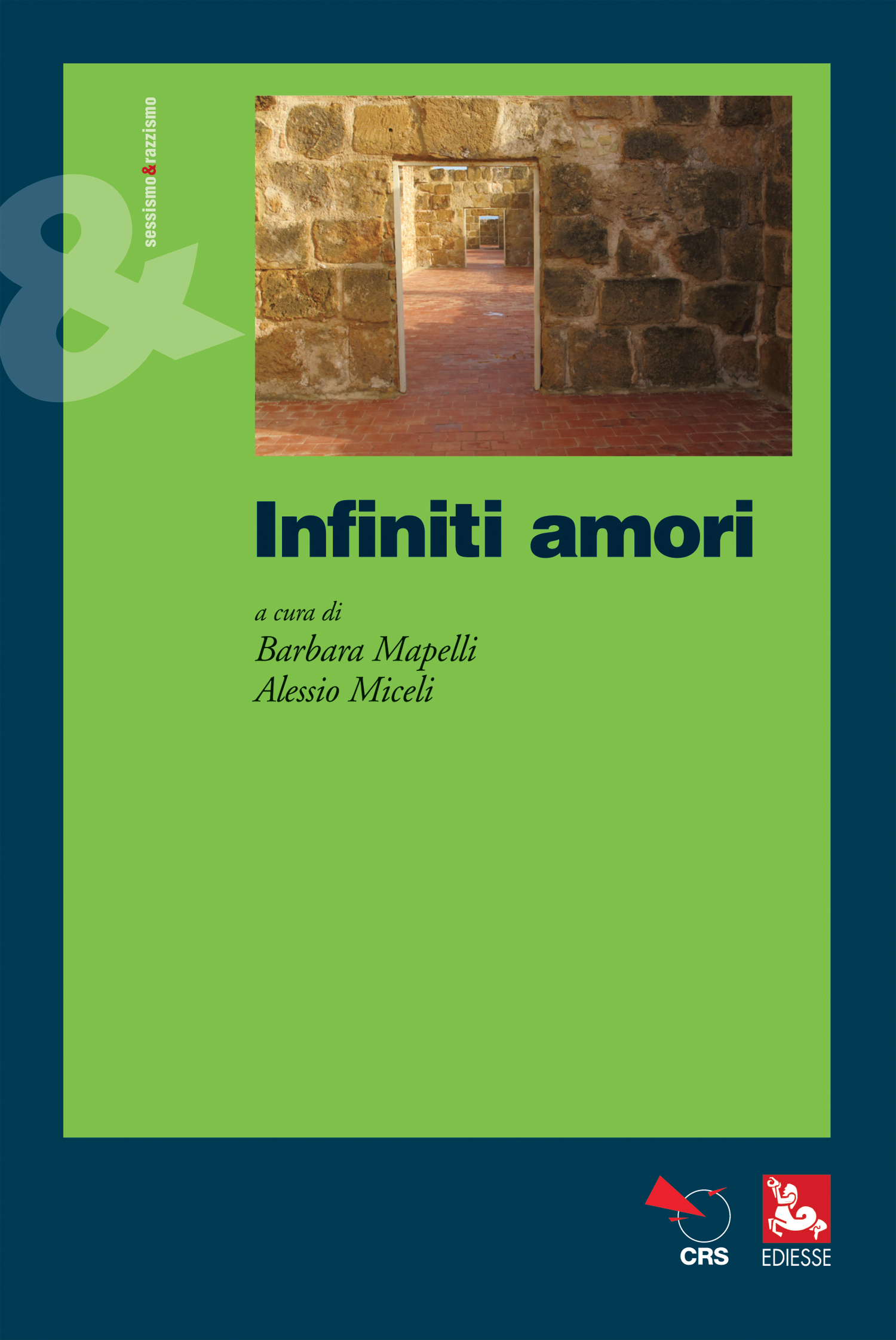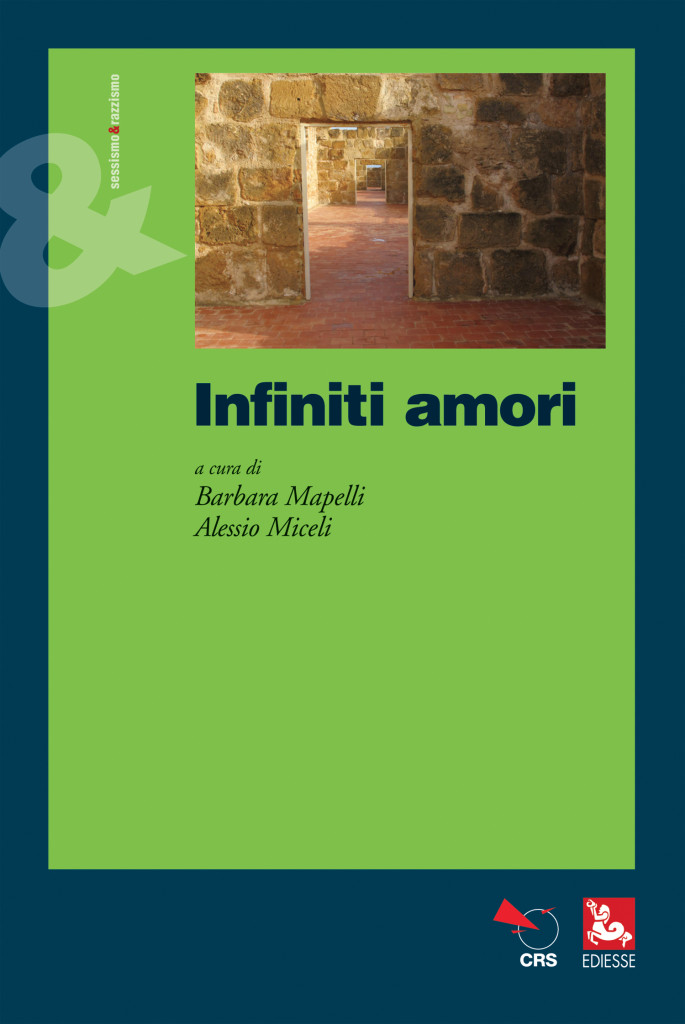di Giacomo Mambriani
Racconto tratto dal testo collettivo “Infiniti amori”, a cura di Barbara Mapelli e Alessio Miceli, Ediesse, Rm 2014)
http://www.ediesseonline.it/catalogo/sessismoerazzismo/infiniti-amori
********
Lei: “A che cosa stai pensando?”
Io: “…”
Lei: “Oh, dico a te”
Io: “Eh?”
Lei: “A che cosa stai pensando?”
Io: “Mmmh… a niente”
Lei: “Ah… a niente”
Io: “Sì, a niente”
Lei: “È che hai una faccia strana…”
Io: “Strana?”
Lei: “Sì, strana”
Io: “Mah… davvero, non penso a niente di particolare”
Lei: “Mmmh… ma se ci fosse qualcosa di particolare me lo diresti?”
Io: “Certo”
Ecco un esempio di scambio tipico delle mie prime storie d’amore, in un’età compresa tra i 17 e i 27 anni circa. C’erano delle varianti, ovviamente, ma il modello era questo, e si riproponeva abbastanza regolarmente.
La mia partner, frustrata e resa insicura dalla scarsità delle mie esternazioni, mi chiede di esprimermi sui temi più disparati, o semplicemente su ciò che mi passa per la testa. Io rispondo in modo evasivo, sentendomi a disagio come se stessi nascondendo qualcosa, ma senza sapere che cosa. A parte un paio di episodi in cui nascondo di proposito il mio pensiero, il resto delle volte semplicemente non riesco a tirare fuori nulla che senta vero o minimamente interessante. Di frequente, l’espressione del mio volto o la postura del mio corpo comunicano molto più di quanto io stesso sappia. Alcune volte, per uscire dall’impasse e riempire il vuoto, ricorro a frasi fatte, piuttosto scontate, oppure do risposte che intuisco essere quelle attese dalla mia interlocutrice. Insomma, brancolo nel buio.
In seguito ho compreso che per orientarmi nelle relazioni mi mancava niente meno che la consapevolezza di me stesso.
La scoperta di sé in relazione con gli altri o le altre costituisce, in un certo senso, l’essenza della giovinezza, se non dell’intera esistenza; ebbene, ciò che le mie prime relazioni amorose mettevano in evidenza era proprio una forte resistenza a scoprirmi e a lasciarmi scoprire (di conseguenza, molto poco potevo scoprire anche dell’altra).
In quanto giovane uomo cresciuto nella cosiddetta civiltà patriarcale, non ero abituato ad ascoltare le mie sensazioni ed emozioni, a dar loro spazio, soprattutto a quelle considerate negative come la tristezza, la paura o il senso di fragilità. Sapevo ben poco di ciò che mi si muoveva dentro, anzi, mi era stato insegnato, indirettamente, a diffidarne. Percepivo il mio desiderio come qualcosa di perturbante di cui avere paura e vergogna. Parallelamente a questo, avevo costruito un’immagine di me che non corrispondeva alla realtà, e spendevo un sacco di energie cercando di renderla credibile per il mondo esterno. Volevo presentarmi come la persona che pensavo di essere: autonomo, equilibrato, altruista, disponibile e capace di amare. Ero letteralmente terrorizzato, senza saperlo, dal giudizio altrui e dal fantasma del rifiuto. Non è un caso che le mie prime due relazioni amorose siano iniziate senza che dovessi correre il minimo rischio di espormi: la prima volta, una soffiata mi rivelò che una compagna di scuola si era presa una cotta per me, perciò andai, per così dire, a colpo sicuro. La seconda volta, il primo passo lo fece la ragazza per cui mi ero preso la cotta io; aveva intuito che se avesse aspettato la mia iniziativa non sarebbe mai accaduto nulla!
In quegli anni, in amore ho usato due pesi e due misure: mentre cercavo di espormi il meno possibile con il mio desiderio, volevo però sentirmi sicuro di quello della mia partner e se per qualche ragione non lo percepivo mi chiudevo ancora di più in me stesso.
Con il tempo, per fortuna, ho smesso di tenere alla catena il mio desiderio e di mettere alla prova quello dell’altra. Ho potuto così sperimentare che, a volte, magicamente, i desideri si incontrano e scelgono di viaggiare insieme, senza sapere quale sia la meta, o addirittura se ci sia una meta al di là del puro fatto di viaggiare insieme. Un viaggio di scoperta, che non si fa bloccare dalla paura dell’imprevisto e dell’ignoto.
Ricordo quando Elisabetta mi ha confessato (a meno di un anno dall’inizio della nostra storia d’amore, che intuivamo duratura) di aver provato attrazione per un altro uomo, incontrato durante un periodo di permanenza all’estero. Ricordo l’emergere della mia gelosia e della mia ansia, ma anche il senso di libertà che lei mi trasmetteva raccontandomi ciò che aveva provato: preferiva affrontare il rischio della mia probabile reazione negativa piuttosto che rinunciare alla verità e complessità del suo sentire. Ho ammirato la sua forza, oltre che l’energia e la consapevolezza del suo desiderio, e ho compreso che quella volontà di condivisione era un segno di fiducia in me e nel nostro legame. Così, invece di vivere il suo racconto come una minaccia, ho potuto sentirlo come un rilancio, come qualcosa che non solo non peggiorava la qualità della relazione, bensì la faceva inaspettatamente crescere. Nominare e accogliere tra noi l’imprevedibilità del desiderio di entrambi, con la conseguente vertiginosa assenza di garanzie, significava rafforzare la nostra intimità e complicità.
Oggi, anche grazie a quell’episodio, ho una fiducia sempre maggiore nella forza vitale e trasformativa del desiderio. So che il suo emergere comporta dei rischi, ma ho sperimentato più di una volta che se si è capaci di esprimerlo e di metterlo in gioco nelle relazioni, assumendosene la responsabilità, quasi sempre si produce un guadagno di spazio, di creatività e di piacere. E non solo per se stessi.
Con il tempo, si è ampliato il significato stesso che davo alla parola desiderio. In passato, da una parte la vedevo legata soprattutto alla sfera sessuale, dall’altra la usavo spesso come un semplice sinonimo di obiettivo, di traguardo da raggiungere. Oggi, invece, per alludere al desiderio senza costringerlo entro limiti troppo angusti, userei una costellazione di parole: apertura trasformazione creatività contatto curiosità scoperta gioco vertigine. E aggiungerei anche due parole che di primo acchito sembrano appartenere ad altre aree semantiche: cura e conflitto.
Andare a convivere con la donna che ami e diventare padre di una figlia di cui ti innamori sono due esperienze tanto meravigliose quanto massacranti: devi imparare a vedere e a fare un sacco di cose che, prima, qualcun altro (quasi sempre una donna) vedeva e faceva al posto tuo! Inizialmente, mi sono rassegnato a questo faticoso apprendistato (fatto di lavatrici, pannolini, pulizia del bagno, pentole sul fuoco, ecc.) nel nome di un astratto ideale di giustizia e di parità tra i sessi. Soltanto in seguito ho cominciato a intuire che dedicare la mia attenzione, le mie energie fisiche e il mio tempo alla cura della vita materiale è un dono che faccio a me stesso, prima ancora che alla mia compagna, a mia figlia o alla collettività.
È un modo di radicarmi nel mio corpo e nello spazio in cui vivo, rispettando e onorando più profondamente la realtà di ciò che è umano. Questo processo di radicamento, da uomo-albero, lo vedo connesso anche alla mia possibilità/capacità di amare: quanto più sviluppo le radici, tanto più protendo i miei rami verso la luce, produco ossigeno, do frutto e offro ospitalità ad altri esseri viventi.
E cresce anche la mia capacità di far fronte ai venti di tempesta, per esempio quelli che soffiano durante un conflitto di coppia!
Ho sempre avuto paura del conflitto e ho per lungo tempo fatto in modo di evitarlo, sia allontanandomene fisicamente, sia elaborando strategie per disinnescarlo il più in fretta possibile, come un artificiere al cospetto di una bomba micidiale. Ho verificato nel tempo quanto fosse controproducente questo atteggiamento e quanto finisse per produrre proprio quelle esplosioni di cui avevo il terrore! Per cominciare a entrare nei conflitti e attraversarli, scoprendone il potenziale creativo e trasformativo, non ho dovuto apprendere delle strategie; è stato sufficiente avvicinarmi di più a me stesso e al mio desiderio, iniziando finalmente a riconoscerlo, a dargli spazio e a rispettarlo. Restare fedele a quello che sento e che voglio, anche quando differisce da ciò che sente e vuole la mia compagna, è onorare me stesso e la relazione, contrariamente a quanto pensavo in precedenza. Senza questo rimanere saldo, paradossalmente, nella relazione non possono avvenire spostamenti significativi, e alcuni nodi rischiano di non venire mai sciolti.
Una questione in cui è bene che uomini e donne rimangano saldi è proprio quella della cura, in cui si intrecciano vari fili che attraversano anche la storia della nostra civiltà. È un tema che, a ben vedere, trascende la dimensione della contrattazione privata e assume una valenza simbolica e politica. Bisognerà dipanare questa matassa poco a poco, con i tempi della pratica e del conflitto non distruttivo.
La mia fatica, riguardo alla cura, è da una parte quella di prendermene la piena responsabilità e titolarità, acquisendo la sensibilità di sguardo nonché la capacità e rapidità di azione che la quotidianità domestica richiede; dall’altra quella di non farmi condizionare dal sarcasmo e dalla svalutazione che circolano, nel discorso comune, a proposito dei cosiddetti “mammi”.
La fatica che sento in Elisabetta è invece, da una parte, quella di lasciar andare (colloquialmente mollare), rinunciando a quella parte di potere/controllo insita nella cura, fidandosi anche del fatto che se molla non accadranno disastri; dall’altra, quella di legittimarsi maggiormente a usare il tempo per se stessa, per fare altro (o anche niente!) senza farsi sviare dagli automatismi o dai sensi di colpa.
È chiaro che si tratta di due movimenti interconnessi, che influiscono l’uno sull’altro, e quindi possono ostacolarsi oppure sostenersi reciprocamente. Tutta quest’opera di mediazione, inoltre, va fatta senza avere in testa un traguardo ideale di armonia e pacificazione. Infatti, nonostante tutti gli avvicinamenti e le mediazioni che possiamo e dobbiamo fare, le nostre idee e pratiche di cura non coincideranno mai completamente ed è un bene che sia così.
Concludo tornando sul versante maschile: spero che in futuro riusciremo ad accompagnare i giovani uomini a scoprire in libertà i propri desideri autentici, compiendo spontaneamente il loro apprendistato al conflitto e alla cura. In questo modo, forse, potranno esprimere una forza diversa da quella proposta/imposta dai modelli tradizionali di mascolinità. Una forza capace di sostenere la vita e non di distruggerla, di difendere le idee senza scatenare le guerre, di reggere lo scacco di un rifiuto o il dolore di una separazione senza ricorrere alla violenza. Una forza maschile che sia finalmente a disposizione dell’amore e delle generazioni a venire.